Tutto principia con un ovo che non vuole saperne di schiudersi. Poi, grazie alla dedizione di un’anatra paziente che continua a covarlo, l’uovo s’apre e ne esce fuori l’anatroccolo più brutto dell’intero fossato.
Il perché già lo conosci: l’anatroccolo non è un anatroccolo, ma nessuno, compreso il protagonista, lo sa o lo vuol sapere. D’altra parte, nuota meglio di tutta la cucciolata e non può essere certo un tacchino, si dice mamma anatra.
Se non sono gigli, son pur sempre figli
Sommario dei contenuti
Dunque, se non è tacchino, non è cicogna, non è pollo e non è gallina, per forze di cose è un anatroccolo, stabilisce mamma anatra decisa a non cedere il passo sull’identità di quel figlio.
E stabilisce così perché del mondo «dall’altra parte del giardino, sino al podere del parroco», lei non sa nulla. Sa che c’è, certo, ma non immagina quante altre specie di animali possano viverci. E non le interessa.
«Se non sono gigli, son pur sempre figli», cantava De André; e mamma anatra ce la mette tutta nel difendere dalle ingiurie il suo figliolo mal riuscito.
Ne giustifica le storpiature di lignaggio con la nascita tardiva. Cerca di convincere le comari del Mondo al di qua del giardino che, benché diverso, merita un’opportunità. Si racconta, e racconta, che il piccolo scherzo della natura crescerà e migliorerà.
Al di qua del giardino, nel piccolo mondo che gira intorno al fossato del castello, là dove nuotano le anatre della nostra fiaba, ci sono certe regole di forma e genere: se sei diverso sei l’eccezione a quelle regole, un portatore di caos, e in quanto tale un emarginato.
Vivere alla periferia di se stessi
Chi emargina chi? Questa dovrebbe essere la domanda da porsi leggendo questa fiaba.
A una prima lettura, la fiaba sembra puntare il faro della vergogna sulle stupide anatre del villaggio e su tutti gli altri animali della storia che sembrano non essere capaci di riconoscere una creatura da un’altra: è l’altro che non ci capisce, non ci apprezza, non ci sa.
Tuttavia, l’altro sa di noi ciò che noi gli facciamo sapere. Questo implica che: se non ci sappiamo noi per primi, l’altro fa di noi la storia che gli pare e che gli è più famigliare. Ed è qui che inizia il nostro processo di identificazione con quella storia.
E qui cade nella trappola anche il protagonista di questa fiaba. Esso infatti non si domanda come mai sia così diverso dagli altri della sua specie. Crede, lui per primo, d’essere un brutto anatroccolo. Fa propria l’identità che gli viene attribuita, ed entra nella parte al punto che non importa quanto provi a fuggire lontano: l’identità gli è addosso come un’ombra e lo segue ovunque vada.
Il brutto anatroccolo vive alla periferia di sé, nell’idem, nell’immedesimazione con quell’aspetto, quel ruolo, quei modi d’essere che lo qualificano anatra anche se anatra non è:
«Non domandava altro se non che gli permettessero di occupare un posticino tra i giunchi e di bere acqua dello stagno»
Dell’immedesimazione
Fuggito dal fossato, scampato a una battuta di caccia, il pennuto protagonista di questa fiaba approda nella cascina di una vecchina così accecata dai propri bisogni (meglio un uovo oggi, che un cigno domani) da volerlo, anche lei, un’anatra.
La vecchina lo accoglie così nella sua corte dove ci sono già un gatto e una gallina: i soli due animali in quella parte di mondo e dunque, per quanto ne sanno, la metà di un mondo intero. E in questa metà di mondo ciascuno ha un ruolo: il gatto sa far le fusa, la gallina sa fare le uova, e la vecchia sa far scintille per accendere un fuoco.
Solo l’anatroccolo – che non fa uova né fusa né tantomeno scintille – non trova una collocazione. E la cosa lo rende triste e di cattivo umore, capace solo di pensare all’aria fresca, al sole, alla sua voglia di tuffarsi nell’acqua e alla sua smania di nuotare.
«Non hai niente da fare; epperò ti prendono così strane voglie. Se tu facessi l’ovo o le fusa, vedresti che ti passerebbero. […] Domanda un po’ al gatto, ch’è il più savio tra quanti io mi conosca, se gli parrebbe un piacere saltare nell’acqua e nuotare! Di me, non parlo… Domandalo, se vuoi, anche a Sua Eccellenza, la nostra vecchia padrona. Più savio di lei, non c’è alcuno al mondo. Ti pare che le possa venir voglia di nuotare, o di sentirsi richiudere l’acqua al di sopra del capo? […] Non vorrai già essere più sapiente del gatto e della padrona. Di me, ti dico, nemmeno voglio parlare. Non farmi lo schizzinoso, bambino; non ti mettere grilli per il capo. Ringrazia il tuo Creatore per tutto il bene che ti ha concesso. Non sei capitato in una stanza ben riparata, e in una compagnia, dalla quale non hai se non da imparare? […] Vedi d’imparare a far l’ovo, a buttar fuori scintille e a far le fusa!»
Risponde la gallina all’anatroccolo che le confida i suoi sogni. E dal suo punto di vista non ha tutti i torti: perché mai un gatto dovrebbe desiderare di far le fusa, quando già le fa? Per quale bizzarra ragione una gallina dovrebbe perdersi in mille pensieri su come sarebbe far uova, quando già ne produce uno al giorno?
Questo, però, quando chi fa quel che farebbe un gatto, è gatto; e chi fa quel che farebbe una gallina, è gallina. Ma un cigno che si identifica con un anatroccolo, cosa può fare se non continuare a smaniare per la vita che non si sta permettendo?
In fondo, a chi non fa quel che è nato per fare non resta che la frustrazione.
Dall’immedesimazione all’individuazione
Ogni identificazione è un processo di immedesimazione a scapito di un processo di individuazione.
Finché rimaniamo fedeli alla parte che ci hanno assegnato, o che ci siamo auto-assegnati pur di entrare nel cast, restiamo divisi dal nostro ipse, dal nostro sé originale.
Per poter abbracciare quell’ipse e diventare individuo (che significa letteralmente <non diviso>), dobbiamo prima di tutto allontanarci dall’identità attribuita, o per dirla con le parole di Roberto Assagioli, padre della Psicosintesi: dis-identificarci.
Dis-identificarci dal nostro essere qualcosa o qualcuno: dalla nostra professione, dal nostro status economico e sociale, dal nostro dolore, dalla nostra malattia, dalla nostra posizione all’interno delle relazioni che instauriamo (figlia/o di, genitore di, marito/moglie di, capo di…).
Non a caso l’anatroccolo sceglie, nonostante i moniti della gallina, di lasciare la cascina della vecchia; di lasciarsi alle spalle l’illusione di un ruolo, la maschera, la parvenza di un posto da chiamare casa.
«Credo che me n’andrò a girare il mondo», afferma infine l’anatroccolo.
«Buon pro ti faccia!», gli dice di rimando la gallina.
Nessuno ci trattiene nell’idem, se non la catena della nostra identificazione. E di nuovo mi avvalgo delle parole di Roberto Assagioli: «Noi siamo dominati da tutto ciò in cui il nostro io si identifica. Possiamo dominare, dirigere e utilizzare ciò da cui ci dis-identifichiamo»
L’anatroccolo lascia la scena e con essa il ruolo da copione. Tuttavia, non ha ancora una sceneggiatura originale da seguire. È da qui che ha inizio il processo creativo. Il passaggio da un idem a un ipse. La rinascita.
Il viaggio verso la rinascita
Al crepuscolo di una giornata autunnale che fa presagire quando sarà duro l’inverno, l’anatroccolo, il nostro autore in cerca della propria storia, incappa in uno stormo di cigni e ne rimane ammaliato.
Grandi, magnifici, di una bianchezza abbagliante, con colli lunghi e flessuosi: non conosce il nome di questi uccelli, tutto ciò che sa è che sono belli come non ne aveva ancora mai veduti. In preda all’emozione più totalizzante, non riesce a levar loro gli occhi di dosso, e in un impeto incontrollabile rivolge allo sciame un grido così nuovo e forte che se ne spaventa.
È ciò che accade la prima volta che sentiamo la nostra voce e rispondiamo inaspettatamente e in modo spontaneo alla chiamata dell’anima: ci sorprendiamo di quanto sia potente e selvaggio il nostro daimon, il nostro essere divino e primigenio; tanto da rimanerne atterriti.
Ma un grido non basta a richiamare il proprio daimon. Ci vuole prima una vera separazione dal mondo così come lo abbiamo conosciuto. Un viaggio fino alla parte più profonda della nostra essenza.
Nelle fiabe, questo antro separato da tutto e tutti è spesso simboleggiato dal bosco, dal ventre della balena, dalla caverna, o dall’inverno, stagione ferma, congelata, in cui ciò che si muove non si vede perché lo fa sottoterra.
E nell’inverno gelido, nella solitudine, nel rischio di non sopravvivere all’inflessibilità del tempo più duro, nel sottosuolo della vita, l’anatroccolo trova la sua semenza.
La rinascita
È primavera. I cigni sono tornati. Il brutto anatroccolo ha superato il suo cimento: è vivo e, ora sì, pronto a realizzare il suo desiderio.
«Voglio volare sin là, presso agli uccelli regali: mi morderanno e mi faranno morire, per avere osato, io così brutto, accostarmi ad essi. Meglio ucciso da loro, che perseguitato dalle anitre, beccato dai polli, respinto dalla ragazza della fattoria, per patire poi tutto quel che ho patito durante l’inverno!»
I cigni, contrariamente alle previsioni dell’anatroccolo, non lo cacciano. E non solo non lo cacciano, ma planando verso di loro, sullo specchio d’acqua, l’anatroccolo per la prima volta si vede riflesso e si scopre cigno a sua volta. Ha trovato il suo ipse. Ha un posto da chiamare casa. E tutti – i cigni come lui e i bambini che lo guardano incantati – finalmente lo riconoscono.
Torniamo alla domanda da cui siamo partiti seguendo il viaggio di individuazione del nostro pennuto: chi emargina chi?
A chi abbiamo ceduto il potere di riconoscerci? Siamo noi a vivere alla periferia del nostro potenziale, o sono davvero gli altri a mettere i confini, a sbarrarci il cammino?
Questa fiaba ci racconta che vale la pena scoprirlo; e mi auguro che anche tu, come il brutto anatroccolo, possa riconoscerti nel magnifico esemplare di umano che sei. Simile ai tuoi simili, ma non il medesimo.
Prova settimanale dell’eroe
Questa settimana ti invito a tenere traccia delle tue identificazioni. Quante volte pensi di essere un pessimo compagno o una pessima compagna; un pessimo figlio o una pessima figlia; un o una pessima collega; un pessimo uomo o una pessima donna; una o un pessimo professionista…?
C’è qualcosa in queste identificazioni che non ha a che fare con te, ma con l’immagine, l’ideale che hai di quel ruolo e con le regole alle quali hai deciso di credere?
Prima di andare in Canada, per esempio, credevo seriamente che avere in curriculum troppe cose diverse facesse di me una persona indegna di fiducia perché, come riportava nero su bianco la mia fedina professionale, le tante esperienze diversificate dimostravano quanto fossi incoerente, indecisa, irrequieta.
In Canada, dove un curriculum vario e pieno di extra è un trofeo da esibire, ho imparato che esistono almeno due mondi: la metà che conosco io, e la metà che mi è ignota. Ed è sempre la terra incognita ad aprire il nostro ventaglio di possibilità.
Hai già visitato la CLIQUE DEGLI AUTORI?
È una nuova sezione in cui puoi trovare nuovi ed esclusivi esercizi di coaching narrativo

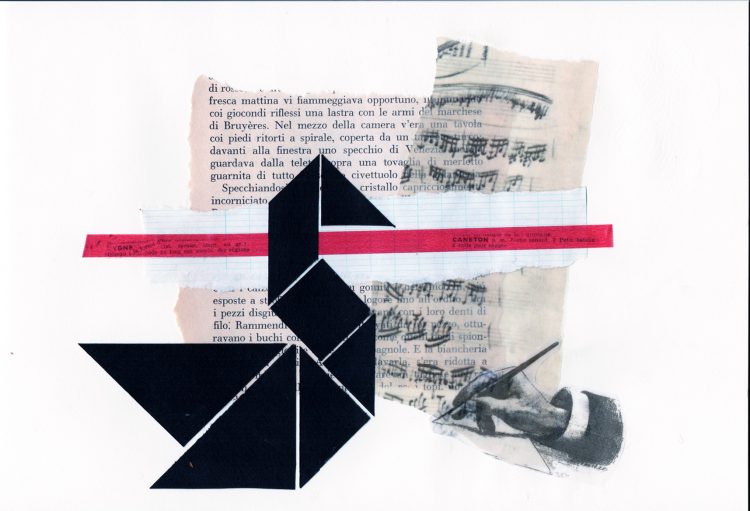
7 Comments
Dalla backstory famigliare alla story personale: la famiglia intrusioni e dictat
[…] Ricordi il discorso sull’identificazione nella fiaba del Brutto Anatroccolo? Finché la nostra identità è determinata dal gruppo, o clan di appartenenza, siamo una storia limitata alla trama che altri intrecciano per noi. […]
Imitazione e influenzabilità: quanto c'è di originale nella storia che portiamo nel mondo? - Coaching in fabula | Carlotta Givo
[…] è molto diverso dal discorso sull’identificazione di cui scrivevo qualche post fa: ciò che subiamo passivamente o inconsapevolmente, ci domina; ciò […]
Vite a debito: la storia della tua energia quando sbagli investimento
[…] Non è questione di egoismo. Si tratta di imparare a distinguere i valori, dagli obblighi. L’individuo, dall’identità. […]
Come diventare stupidi: istruzioni per vivere come zombie e illudersi di essere felici - Coaching in fabula | Carlotta Givo
[…] evitare di attirare l’attenzione, occorre omologarsi, ovvero portare avanti il discorso dei più; entrare a far parte di una corrente che convogli allo […]
Meccanismi di compiacimento, riflessioni, impressioni e ribellioni | Coaching in fabula | Carlotta Givo
[…] (Puoi approfondire il tema dell’identificazione qui) […]
2.2020 | Le carte Miriorama | Coaching in fabula | Carlotta Givo
[…] Io e la matematica abitiamo galassie diverse e nemmeno ci provo a fare il calcolo per verificare l’attendibilità dell’annuncio di Leigh. Mi lascio però irretire dalla dichiarazione e la cosa mi fa letteralmente sobbalzare dalla sedia perché immediatamente immagino la mia vita, la nostra vita, proprio come un’opera dipinta seguendo la linea dell’orizzonte disegnata dal daimon. […]
7.2020 | Scrivere di paura con le api in testa | Carlotta Givo
[…] Parti poco utili alla drammaturgia del personaggio in scena. Parti sofferenti che a un certo punto si è rinunciato a guarire, preferendo nasconderle, adulterarle e travestirle. […]